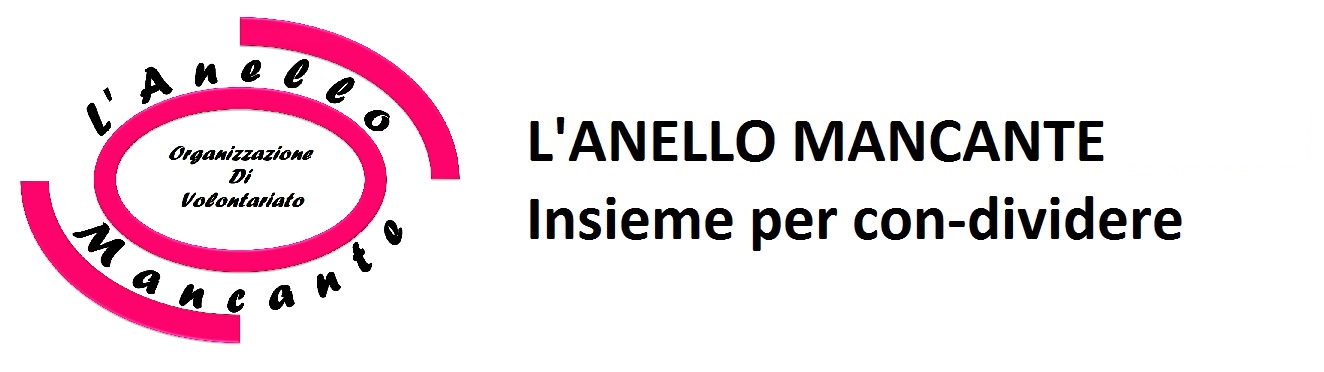Da Corriere.it del 11/03/2020
di Antonio Scurati
A differenza di padri e nonni, non abbiamo conosciuto la guerra, né la politica come senso di appartenenza a un comune destino. Ora è arrivato il nostro momento.
Siamo stati la generazione più fortunata della storia dell’umanità. Noi, nati in questa meravigliosa penisola protesa su di un mare «buono» nel mezzo del più lungo periodo di pace e del più grande benessere mai goduto dall’Occidente europeo, noi siamo stati la jeunesse dorée della storia universale. Ora, entrati nell’età che dovrebbe concedere la maturità, raggiungiamo il «punto alto» della nostra esistenza, siamo chiamati alla prova. Ce ne mostreremo all’altezza?
Non sto parlando di felicità. Forse altre generazioni, più tormentate, meno agiate, più disperatamente vitali della nostra, sono state anche più felici. Parlo di fortuna. Come ho scritto all’inizio di questa maledetta epidemia, l’essere nati in Italia al principio degli Anni 70, ci ha consegnati, per puro caso fortunato, al pezzetto di umanità più agiata, sana, sicura, protetta e longeva, meglio vestita, nutrita e curata che abbia mai calcato la faccia della terra.
Non sto, ovviamente, nemmeno affermando che questo nostro privilegio assoluto ci abbia individualmente preservato dalla sofferenza, dalle avversità, talvolta dalla malattia. Sto parlando di ciò che appartiene alla dimensione della vita comune, degli orizzonti storici collettivi, dei destini generali. In quella sfera non si può negare che siamo stati baciati dalla sorte.
A cominciare dal fatto che la nostra carne non abbia mai conosciuto il morso della guerra. Certo, avevamo vent’anni la notte del 17 gennaio del 1991 quando gli aerei della coalizione anti-Saddam bombardarono Baghdad in nome nostro e in diretta televisiva. Ma si trattò, per l’appunto, di una «inesperienza», cioè di un’esperienza deprivata dei tratti caratteristici dell’esperienza vissuta: la continuità, l’irreversibilità, la fatidicità. Dopo aver assistito allo spettacolo di morte e distruzione, si poteva spegnere la tv e andarsene a letto. Anzi, non c’era altro da fare, non c’era alternativa all’assurdo: sebbene reale, devastante, letale, la guerra sarebbe rimasta per noi una serata trascorsa davanti alla televisione. Certo, avevamo trent’anni la mattina dell’11 settembre 2001, e ne fummo sconvolti, ma la malvagità distruttiva di quell’epocale atto di terrorismo consisteva proprio nel colpire un bersaglio simbolico per moltiplicarne su scala planetaria gli effetti mediatici.
Anche le nostre vite hanno indubbiamente avuto la loro dose di preoccupazioni, angosce e inquietudini ma, scaturite da un altrove reale, ci hanno investiti per lo più come piaghe dell’immaginario collettivo. Anche noi abbiamo vissuto in un’epoca di profondi e vorticosi mutamenti ma, paradossalmente, nella nostra epoca le rotture epocali non si sono manifestate per noi sotto forma di guerre, rivoluzioni e migrazioni di popoli, come fu per i nostri padri e nonni.
Tutte queste cose hanno sempre riguardato gli «altri». Noi siamo stati guerrieri da salotto, bagnanti sulle spiagge dei migranti, i nostri drammi hanno assunto la forma di psicodrammi, la sindrome da attacchi di panico è stata la patologia psichiatrica tipica della nostra psiche collettiva. Quando si è colti da un attacco di panico l’organismo attiva un processo psico-sensoriale adatto alla presenza di una minaccia mortale (iperlucidità, scariche adrenaliniche, aumento della frequenza respiratoria). Una reazione utile se s’incontra un leone nella savana. Solo che, nel caso del panico, il leone non c’è.
Adesso, purtroppo, il leone c’è. E, come in una sorta di beffarda nemesi storica, ha assunto la forma impalpabile, microscopica, quasi fantasmatica, ma terribilmente reale, e potenzialmente ubiqua, dell’epidemia. La minaccia letale c’è e può essere dappertutto. La crisi che sta generando ricorda per alcuni aspetti gli scenari di guerra: strade deserte, persone chiuse in casa,reparti di rianimazione degli ottimi ospedali lombardi in cui i medici sono drammaticamente costretti a decidere quali pazienti curare e quali lasciar morire.
A giudicare da certe situazioni vergognose si direbbe che la nostra fortunatissima generazione sia giunta alla prova di maturità capace solo di panico (le fughe sui treni notturni) o d’irresponsabilità (le code agli impianti sciistici). Non posso rassegnarmi a credere che sia così. Di certo ci siamo giunti inesperti di ciò che da sempre definisce la condizione umana: la piena coscienza della nostra mortalità, la lucida e matura consapevolezza che vita e morte si snodano l’una accanto all’altra come strade complanari, contigue e di pari importanza.
Siamo stati, in altri termini, una generazione impolitica. Viandanti solitari sui sentieri della ricerca di una felicità individuale, non abbiamo conosciuto la politica come sentimento di appartenenza a un comune destino. Ebbene, dobbiamo assolutamente scoprirla ora. E dobbiamo imparare in fretta. Dobbiamo rimediare al lento apprendistato che non abbiamo avuto. Appartenere a una comunità di destino, a una comunità politica, significa anche elevarsi all’altezza di un sentimento tragico della vita, lottare per la vita, desiderare la vita sapendo di «galleggiare in un luogo incerto tra due estremi, tra l’essere e il nulla».
Per tutti questi motivi io ritengo che sia giunto il momento della politica, nel suo significato più alto, e, perciò, benedico la decisione politica che ha trasformato l’intera Italia in zona rossa contro l’arbitrio degli individui, il loro panico e le loro irresponsabilità.